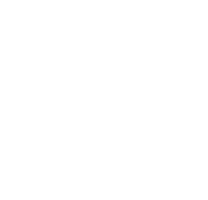Come ridare senso alla parola “umanesimo”, chiedeva pensosamente Jean Beaufret subito dopo la seconda Guerra Mondiale. E Heidegger gli rispondeva con la “Lettera sull’umanesimo” che, con un inspiegabile calco sul tedesco “humanismus”, venne tradotta come “Lettera sull’umanismo”, dando vita a una serie di derivati curiosi (antiumanismo, ad esempio) e di pensosi distinguo tra “umanismo” e “umanesimo”. Già, come ridare senso all’umanesimo o, se si preferisce, all’umanismo? Intanto, conoscendolo nella sua vera natura, come ci aiuta a fare Michele Ciliberto, massimo studioso dell’umanesimo italiano, in questa introduzione con antologia accessibile e intelligente, Il nuovo Umanesimo (Laterza).
Umanesimo, nella coscienza comune, è un pensiero puramente letterario (quasi un non pensiero) nemico della scienza (di qui l’annosa questione delle “due culture”), estraneo alla tecnica, o tecnico involontariamente, essendo una macchina per produrre discorsi retorici. Ma abbiamo eccellenti motivi per sostenere il contrario. L’umanesimo si manifesta ogni volta che una crisi, come suggerisce Ciliberto, ci costringe a ripensare la natura umana. Dove “crisi” non è solo un indice di decadenza, ma anche il segnale di una trasformazione e un arricchimento che ha il proprio protagonista nella tecnica. Così è stato al tempo di Platone e dei Sofisti (svolta tecnica: l’alfabetizzazione di massa), al tempo degli umanisti (svolta tecnica: la stampa), e adesso con il web. Conclusione ovvia ma non sempre rilevata: l’umanesimo è una tecnica, e bisogna trovare delle tecnologie umanistiche adatte ai nostri tempi. Questo non è un semplice voto, ma un fatto, che ci viene suggerito, da alcuni libri importanti usciti recentemente.
Il comparatista Michele Cometa, in Perché le storie ci aiutano a vivere (Raffaello Cortina) ragiona su una disciplina di nuova formazione, la biopoetica, che getta un ponte tra le scienze cognitive, il darwinismo, la poetica e la paleoantropologia. La natura e lo spirito non sono due dimensioni contrapposte, sono i due volti di una medesima realtà che comunicano attraverso la tecnica, una delle cui forme più antiche è proprio la composizione di narrazioni, di quelle trame la cui origine non è diversa da quelle dei tessuti che ci accompagnano sin dal paleolitico. Gli umani, anche prima di parlare, raccontavano, tessevano trame con gesti, segni, tracce. E la nascita del linguaggio non decreterà certo la fine di questi storytelling muti e duraturi. Insediamenti come le grotte di Lascaux sono delle grandi forme di trasmissione di racconti che furono visitate non per le misere centinaia d’anni delle nostre cattedrali, ma per migliaia di anni, con una stratificazione che ha visto crescere il suo significato nel corso di questi tempi lunghissimi.
Ma come è possibile raccontare ciò che non si sa? Perché indubbiamente i nostri antenati non erano consapevoli di fare storytelling parietale. La risposta viene dall’ultimo libro dello psicologo americano Daniel Dennett: From Bacteria to Bach and Back (W.W. Northon & Company), una riflessione sulla tecnica come competenza senza comprensione. Come già ricordava un grande esponente della tradizione umanistica, Vico, per cui homo non intelligendo fit omnia: gli umani agiscono prima di comprendere, e la comprensione, se e quando arriva, non è la premessa (come pensano i cartesiani) ma il risultato. L’immagine più potente in cui Dennett condensa il suo discorso è il paragone tra un termitaio e la Sagrada Familia a Barcellona. Sembrano uguali, ma come è possibile? Gaudì ha fatto dei piani, ha avuto delle rappresentazioni, le termiti no. Ma proprio questo è il punto: nemmeno i neuroni di Gaudì hanno avuto delle rappresentazioni, hanno semplicemente “scaricato”, esattamente come le termiti, che in fondo hanno trovato una scorciatoia: invece di creare delle rappresentazioni, come i neuroni di Gaudì, hanno direttamente creato la Sagrada Familia. Così pure, la lunghissima tradizione che ha portato a creare selci sempre più raffinate non è stata dettata da un progetto, ha incamerato il sapere nell’oggetto e lo ha trasmesso, con progressive evoluzioni, da una generazione all’altra.
Il che suggerisce che il tratto fondamentale dell’umano va cercato appunto nella capacità tecnica: l’umanesimo è anzitutto un manesimo, un uso sempre più esperto della mano. È la riflessione su cui si concentra il filosofo britannico Colin McGinn, in Prehension. The Hand and The Emergence of the Humanity (The MIT Press, 2015), si concentra sulla funzione della manualità per la genesi del pensiero. Senza mani, e senza l’esperienza del manipolare e dell’afferrare, non avremmo avuto pensiero, senza la competenza della manualità non avremmo avuto la comprensione. Le mani com-prendono, afferrano (lo sapeva benissimo Hegel che riconosceva nel tedesco Begriff, “concetto”, l’erede del verbo greifen, “afferrare”), indicano, e che, indicando senza afferrare, facendo dei gesti, avviano la produzione di simboli. È un tema centrale della filosofia, da Aristotele e Anassagora a Heidegger e Derrida, ed è tutto sommato un peccato che McGinn non lo ricordi (tranne un rapido riferimento a Heidegger), ma forse semplicemente non lo sa.
I gesti sono forse geroglifici transitori, come diceva Bacone, ma la loro codificazione rituale nella memoria di una società, oltre che la loro fissazione figurativa o letteraria ne garantisce la trasmissione storica, come suggeriva a metà dell’Ottocento Andrea de Jorio, in La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano che – con un evento che porterebbe alla rivalutazione di Jorio da parte dell’Anvur, l’agenzia nazionale per la valutazione della ricerca universitaria notoriamente impressionata da tutto ciò che è anglofono – è stato pubblicato in traduzione inglese nel 2000 dalla Indiana University Press. Tra i gesti e le tecniche, da una parte, e lo spirito e l’immaginazione, dall’altra, non c’è discontinuità, ma si tesse piuttosto la grande trama dell’umano. In un libro che ha avuto una grande e meritata fortuna, e a cui sono particolarmente affezionato perché Eco me ne raccomandò la lettura l’ultima volta che lo vidi, Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità (Bompiani, 2015) lo storico israeliano Yuval Noah Harari sostiene che ciò che sta alla base dello sviluppo umano è l’immaginazione. Tesi giustissima, profondamente umanistica e radicalmente vichiana. I libri che ho ricordato oggi suggeriscono però che questa immaginazione non sta solo nella nostra testa, ma anche nelle nostre mani e nei loro manufatti tecnici.